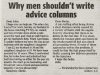di Carmine De Pascale
L’assunzione di un comando avviene spesso per automatismo, come naturale conseguenza di una progressione di carriera. Purtroppo, questa transizione non sempre è accompagnata da una preparazione specifica e mirata, capace di formare il comandante non solo tecnicamente, ma soprattutto sotto il profilo umano, etico e della personalità.
Comandare non è una funzione meccanica né un diritto acquisito: è un’azione che richiede consapevolezza, visione e una profonda comprensione della responsabilità che si assume. Il comando non si improvvisa e non si eredita — si costruisce.

Le Derive dell’Autorità: Leadership Distorta e Frammentazione del Gruppo
Non è raro osservare, anche in contesti strutturati come quello militare, comandanti che tentano di imporsi attraverso l’autoritarismo, confondendo rispetto con timore. Questo abuso di potere, spesso alimentato da frustrazioni personali non elaborate o da insicurezze interiori, può trasformare il ruolo di comando in una valvola di sfogo invece che in un punto di riferimento.
La tentazione di far parlare di sé, di cercare la popolarità o la visibilità ad ogni costo, induce ad intraprendere iniziative e decisioni poco ponderate e talvolta inutili che incidono in modo negativo sul morale dei singoli e sulla coesione del gruppo. Tali atteggiamenti, lungi dal consolidare la disciplina e l’efficacia operativa, generano disgregazione del gruppo, perdita di fiducia e pericolosa inefficienza. La popolarità, intesa come il far parlare di sé e sentirsi importanti, basata sul timore non è autorevolezza, ma debolezza mascherata. È fondamentale riconoscere che la coesione non si costruisce con imposizioni, bensì con l’esempio, il dialogo e la capacità di guidare con empatia e fermezza.
Per questo motivo, l’azione di comando deve prevedere anche una preparazione psicologica e relazionale del comandante, perché nessuna strategia può compensare gli effetti deleteri di un comando esercitato come dominio personale.
In ambienti dove il comando personale è dominante, il rapporto tra comandante e subordinati perde la dimensione collaborativa e si irrigidisce in una relazione gerarchica vissuta come oppressiva. Si possono creare fratture nel gruppo, calano la fiducia e il morale e aumenta il rischio di passività o resistenza silenziosa. La coesione interna viene compromessa e il personale dell’unità agisce per obbedienza cieca e non per motivazione condivisa. L’iniziativa individuale viene scoraggiata per timore di punizioni o ritorsioni, tipo “ti faccio trasferire”, licenze negate nel periodo di bisogno, servizi onerosi o possibili riflessi negativi sulla documentazione caratteristica personale.
Buonismo o paternalismo: mancanza di chiarezza dei ruoli e delle responsabilità
Il rovescio della medaglia è l’esercizio del comando buonista o paternalistico, che sebbene spesso animato da buone intenzioni, può generare effetti controproducenti tanto quanto il comando autoritario.
Il leader o il comandante manifesta una protezione eccessiva ponendosi come “padre” del gruppo, evitando decisioni difficili o scontri per mantenere l’armonia. Tende a minimizzare gli errori, evitare rimproveri e giustificare comportamenti scorretti. Il rapporto diventa quasi familiare, a scapito della chiarezza dei ruoli e delle responsabilità.
Il paternalismo genera confusione nei rapporti gerarchici e indebolisce il principio di responsabilità individuale. La mancanza di rigore mina la prontezza operativa e può condurre a comportamenti lassisti a discapito del senso della disciplina, che tenderà a calare. Per paura di dispiacere o ferire, il leader comandante evita scelte impopolari e nei suoi discorsi tende a compiacere per guadagnare il consenso e l’ammirazione dei dipendenti, anteponendo il loro bene fisico, mentale e spirituale agli obiettivi istituzionali.
Nel contesto militare, il comando deve saper educare senza coccolare, guidare senza opprimere. L’equilibrio tra autorevolezza e umanità è la sfida continua della leadership, dove né l’eccesso di durezza né quello di dolcezza garantiscono successo. Il buonismo disinnesca la funzione strategica del comando, perché mette le emozioni sopra gli obiettivi.
La preparazione del Comandante: una necessità strategica
Alla base dell’esercizio di una valida ed efficace azione di comando c’è la preparazione, intesa come processo articolato e strategico pensato per sviluppare competenze operative, decisionali, etiche e relazionali. In Italia, come in molte forze armate moderne, esistono diversi metodi e percorsi formativi che si adattano al grado, al ruolo e al contesto operativo del comandante.
Il sistema formativo nazionale è ricco, diversificato nell’intensità e nella durata e tende a soddisfare le molteplici esigenze di formazione, specializzazione e preparazione allo svolgimento di incarichi specifici. È davvero difficile trovare qualcosa di sbagliato o inefficace: il personale viene ben preparato. Nelle nostre Forze Armate e nei Corpi armati dello Stato si attribuisce una fondamentale importanza alla preparazione del personale, fino a considerarla continua e permanente.
Eppure, nonostante tutto l’imponente sistema formativo messo in campo, gli episodi di abuso di autorità da un lato e di eccesso di buonismo dall’altro lato, continuano a verificarsi con conseguenti danni, sia sui singoli che sui gruppi. Alcuni fatti emergono perché denunciati o troppo evidenti per avere continuità nel tempo e vengono sanzionati secondo le norme a secondo del caso. Altri fatti o situazioni rimangono nell’ombra, anche per lungo tempo, per il timore di ritorsioni o di conseguenze negative per chi si trova in uno stato di subordinazione gerarchica o psicologica.
Nulla di nuovo, è quello che si è sempre accaduto da secoli e continuerà a verificarsi perché taluni comportamenti, principi e sentimenti sono insiti nella natura dell’essere umano, come la sete di potere, il prevalere sugli altri, l’affermazione e la ricerca del riconoscimento della propria autorità, le ambizioni spropositate, la mancanza di sensibilità del dolore altrui. Se non fosse così, non ci troveremmo oggi ad essere testimoni di tante guerre, conflitti più o meno estesi e dispute nel mondo, nonostante il raggiungimento di un elevato grado di civiltà e di progresso.
Si tratta solo di riuscire a mitigare il più possibile gli effetti distorsivi di una possibile azione di comando inappropriata, permeata sicuramente dall’educazione, dai valori e dal vissuto di chi comanda. Per questo, ad integrazione dei corsi di istruzione presso le scuole ed i centri di formazione, punterei anche su quella funzione educativa ed etica che potrebbe essere espressa tra superiore e subordinato nel contesto delle varie articolazioni gerarchiche.
L’azione di comando non è solo una questione di gerarchia o efficienza organizzativa: è soprattutto una forma di relazione. E quando questa relazione è priva di umanità, si rischia di svuotare di senso il lavoro stesso. Un comando basato solo su moduli, scadenze e organigrammi genera alienazione. Quando invece il superiore sa trasmettere senso, fiducia e motivazione, ogni indicazione acquista valore umano e professionale, evitando così che il rapporto si basi solo su ordini, direttive impersonali e sul rispetto meccanico delle regole.
Giusto per citare un esempio, Dwight D. Eisenhower, generale durante la Seconda Guerra mondiale e poi presidente degli Stati Uniti, era noto per il suo stile collaborativo e per le capacità di motivare le truppe attraverso il rispetto e la chiarezza degli obiettivi. Era solito promuovere la responsabilizzazione dei suoi ufficiali, evitando il comando autoritario.

Il superiore è un esempio vivente dei valori dell’organizzazione ed ha un ruolo che va ben oltre l’esecuzione degli ordini. La sua funzione educativa può contribuire a trasformare l’ambiente lavorativo in uno spazio di crescita e di rispetto reciproco. Pertanto, è fondamentale che riconosca i punti di forza e le potenzialità del subordinato ed offra strumenti e supporto continuo per favorirne il miglioramento professionale.
Commettere degli errori è umano, chi non sbaglia? In linea generale, sarebbe più costruttivo lavorare sulla causa che ha generato l’errore piuttosto che sulla colpa. Come pure durante la revisione del lavoro, invece di segnalare solo gli errori, il superiore dovrebbe evidenziare anche ciò che è stato fatto bene, suggerire miglioramenti e indicare esempi.
In questo modo, si alimenta un clima di apprendimento continuo e il comando non si percepisce come imposizione, ma come guida e le persone sentono di contare davvero. Il subordinato desidera essere visto, compreso e coinvolto e si sentirà proattivo e responsabile.
A difesa del sistema, si dirà “nulla di nuovo, si è sempre fatto così”. Comunque, non si vuole imputare una colpa ad alcuno, si tratta solo di umanizzare i rapporti. L’uso diffuso della tecnologia – pur ampliando la possibilità di comunicazione – fa perdere il contatto umano, soprattutto quando ci si affida solo a schemi e messaggi digitali. Il rischio è che le relazioni diventino superficiali e impersonali, fredde.
Certo che dedicare tempo alle relazioni umane, all’ascolto, ai dialoghi informali e non solo alle riunioni funzionali comporta impiego di energie e tempo, tutto questo diventa stancante e stressante. Il più delle volte si è presi da tanti compiti e pratiche da espletare che non si ha tempo per rivolgere attenzione nemmeno a sé stessi.
Per questo, potrebbe essere utile strutturare l’azione di comando educativa integrandola nel sistema dei rapporti gerarchici, come modus operandi della gerarchia che mira all’assolvimento dei compiti istituzionali attraverso la partecipazione attiva del personale. Si crea così una cultura in cui il “come” conti quanto il “cosa”.
Con questo approccio, il comando non è più solo uno strumento di organizzazione, ma “leva di crescita”. Ogni subordinato non è un esecutore, ma un professionista in costruzione./La Giustizia