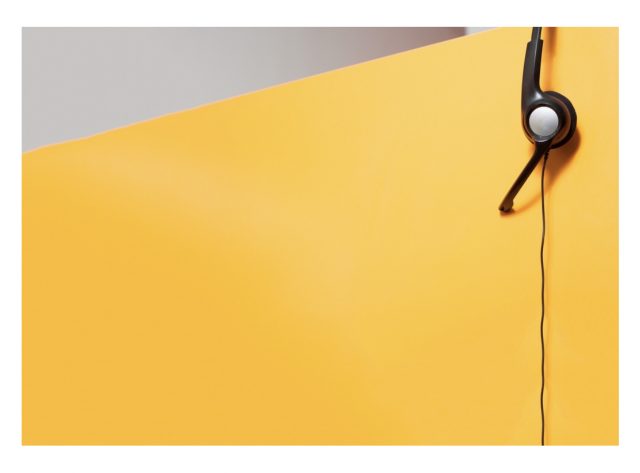Chi sono i ragazzi albanesi dei call center? E cosa pensano dei colleghi italiani – che hanno intrapreso la “rotta contraria”, dall’Italia all’Albania, in cerca di lavoro? E qual è il mondo – e l’idea di mondo – che si muove grazie a loro ma soprattutto dietro di loro? Un’intervista a Stefano Grossi, regista del documentario “Rotta contraria”
Di Valentina Vivona, Osservatorio Balcani
Presentato in anteprima al festival Bif&st di Bari lo scorso 28 aprile, il documentario “Rotta contraria” di Stefano Grossi si annuncia come racconto dell’emigrazione dall’Italia di quei ragazzi e quelle ragazze impiegati nei call center di Tirana.
Il boom del telemarketing in Albania è stato più volte trattato da OBCT negli ultimi anni. Gli autori che si occupano per noi di questo paese hanno cercato di contrastare la retorica dei media italiani riguardo al presunto ‘miracolo economico albanese’. Tra questi anche l’intellettuale Fatos Lubonja che, in un articolo del 2015, definiva ‘schizofrenico’ il tentativo di “vendere all’estero questa realtà come una sorta di paradiso, per fare poi di questi articoli e reportage la superficie su cui invitare i cittadini a specchiarsi“.

La locandina di “Rotta contraria”
Lubonja è una delle principali fonti e voci del documentario di Stefano Grossi, al punto che una sua citazione appare anche nella locandina: “Se volete vedervi allo specchio, guardate l’Albania”. La metafora dello specchio aiuta a decifrare non soltanto la scelta del regista di riprendere gli intervistati e le intervistate attraverso un vetro, ma il senso dell’opera. Più che un racconto, “Rotta contraria” è infatti un saggio sulle conseguenze delle politiche neoliberiste, di cui l’Albania rappresenta un caso-studio o, per l’appunto, un riflesso. I call center sono, per stessa ammissione del regista, solo un pretesto per parlare di un modello di sviluppo fuori controllo.
Il documentario si può dividere in tre blocchi: la questione call center viene esaurita nei primi venticinque minuti dalle diverse esperienze degli otto operatori intervistati, equamente divisi tra donne e uomini, albanesi e italiani. L’ammonimento di Agron Shehaj, proprietario della catena di telemarketing IDS e deputato del Partito Democratico, sul rischio di nuova diaspora della gioventù albanese nel caso in cui i call center chiudano, segna l’inizio del secondo blocco. Le immagini scivolano all’indietro verso la fine del regime di Hoxha, l’emigrazione albanese dei primi anni Novanta, la transizione democratica che culmina nella terza e ultima parte con il racconto della discarica di Sharre alle porte di Tirana. Un viaggio mentale scandito, dall’inizio alla fine, dai guaiti dei cani rinchiusi nelle celle dell’International Pet Hospital della capitale albanese. Il regista Stefano Grossi ha raccontato le sue scelte stilistiche al Cinema Astra di Trento lo scorso 18 giugno.
Stefano, cosa rappresentano i cani nel tuo documentario?
Ho scoperto l’International Pet Hospital di Tirana quasi per caso, rimanendo colpito dalla contraddizione in cui vivono gli animali ospitati. Mi spiego: in Albania non esistono canili, per cui i randagi rischiano di essere uccisi se non vengono ricoverati. In questo centro ricevono ogni tipo di cura, le loro celle sono spaziose, tuttavia ne sono allo stesso tempo prigionieri. Vivono la stessa contraddizione degli operatori dei call center, catturati dietro i vetri dei call center da condizioni contrattuali favorevoli, o meglio, più favorevoli rispetto a quello che offre, in media, il mercato in Albania. In questo senso i cani rappresentano la sintesi dei vari livelli del film. I loro guaiti sono il lamento di una vita che non hanno deciso.
Come nasce il film? E quali sono state le sue fasi?
Per me i documentari sono un’opera di saggistica. Anche nel mio precedente documentario “Nemico dell’Islam” sul regista tunisino Nouri Bouzid, ho usato le vicende biografiche del protagonista per parlare di religione e altri temi più complessi. In un periodo storico dove si parla tanto di migrazioni, io volevo offrire una prospettiva sul tema ‘dalla sponda opposta’. I numeri della migrazione italiana in Albania sono piccoli, ma dicono tanto del nostro paese. Mi interessava questa contro-narrazione per andare a sviscerare cosa è davvero la migrazione: una lacerazione psichica, prima che fisica. In definitiva, si emigra solo se si deve. C’è poi una dimensione letteraria che deve tanto al mio amico Fatos Lubonja, che conosco dal 2009 dopo averlo voluto tra i protagonisti del mio “Diari del Novecento”. Ho letto tantissimo durante la produzione di questo film.
Come sei arrivato alla discarica di Sharre? Per caso, come per i cani, o per scelta?
No, sapevo dall’inizio che avrei parlato della discarica e sapevo dall’inizio cosa avrebbe rappresentato nel film. A me non interessava raccontare la vita degli operatori di call center, italiani o albanesi che siano. Le loro testimonianze sono solo un contrappunto musicale, una metafora del nostro modello di sviluppo che riconosce solo la funzione merceologica della vita. L’Albania è il laboratorio a cielo aperto di tutte le contraddizioni del nostro modello, la discarica il suo emblema, il punto di arrivo del ragionamento. Luigi Pintor, fondatore de “Il Manifesto”, in un’intervista mi aveva parlato del “mondo come mattatoio sopra un immondezzaio”. Così l’ho voluto riproporre, come grido di allarme. Sapevo anche che i volti degli attivisti di Akip intervistati sarebbero stati gli unici nitidi perché rappresentano la realtà. La storia di questo movimento ambientalista albanese meriterebbe un documentario a parte.
Cosa hanno pensato gli intervistati della tua scelta di sfocare i loro visi?
Nessuno di loro ha ancora visto il film, ma presto ci sarà una proiezione a Tirana. Per me sarà molto dura tornarci, la capitale albanese mi sembra davvero esprimere la follia del mondo in cui viviamo. La maggior parte delle riprese sono notturne perché i contrasti di questa città-flipper sono ancora più forti.